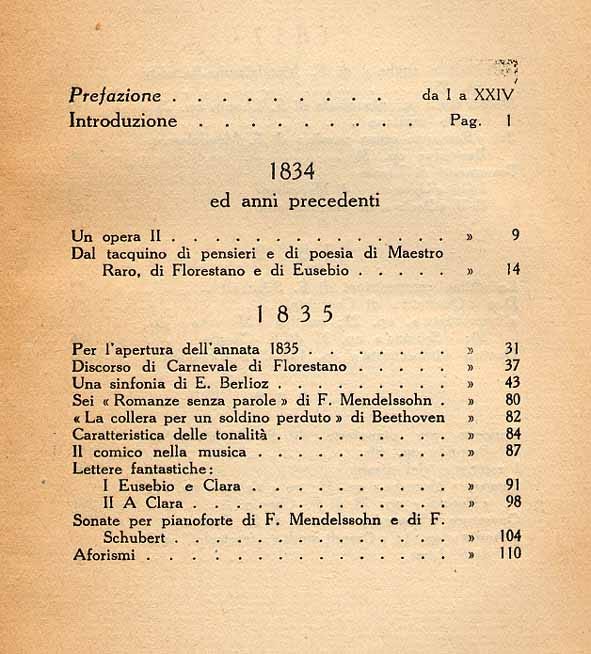Promesse, veggenti e hic et nunc dell'opinione
Per un'ecologia dell'ascolto, a prescindere da ogni pandemia
Nella lettera “del Veggente” del 1871, Arthur Rimbaud confessava all’amico Paul Demeny i motivi per cui il poeta doveva coltivare sensazioni estreme e liberare la “sregolatezza dei sensi”, così da giungere all'ignoto e creare del “nuovo”. È considerato il primo vero manifesto dei movimenti d'avanguardia letteraria e della poesia moderna, quella in cui le prime teorie sulla funzione sociale e spirituale della poesia si integravano a quella “autentica e limpida ribellione romantica”, traduzione artistica di necessità fino a quel momento sopite.
Negli stessi anni, Mozart era tacciato di rendere l’arte musicale ineffabile. L'opinione diffusa di chi lo ascoltava era che la sua fosse una musica troppo difficile, per quanto superiore. E per smentire quelle sciagurate tesi, su lui e sui romantici, ci sono voluti decenni.
Siamo saltati subito sulla musica perché, molto semplicemente, è proprio in quel momento storico che entra in scena la critica musicale, quella che l'ignoto e il nuovo doveva cercarlo nell’arte dei suoni. Erano per lo più musicisti, colleghi di solito un po’ meno conosciuti di chi si esibiva regolarmente, a recensire i concerti. A meno che non ti chiamavi Schumann, eri un equilibrista che tra spartiti, penna e carta stampata tenta di fare di questa educazione la risposta ad un bisogno: far capire al pubblico ciò che sta ascoltando, dispensando tra le righe i suoi personali giudizi.
Ma è sempre così semplice “educare all’ascolto” rimanendo oggettivi?
Qualche anno fa, Drew Millard si chiedeva su Noisey se esiste, davvero, un modo per capire come fare una recensione musicale oggettiva (How Do You Even Write an Album Review Anymore?). Era il 2017, ma a leggerlo adesso è come fosse uscito ieri.
Certo, di acqua sotto i ponti ne è passata, e quest’arte – quella della critica musicale – è davvero cambiata radicalmente, nel frattempo. Facendo riferimento al cervello critico di Hume, l’articolo suggeriva che un buon viatico è usare la conoscenza della materia per confrontare un'opera su più livelli: in modo mitigato ma allo stesso tempo penetrante, bisognerebbe stabilire il contesto in cui l'opera nasce, per poi muoversi sul contorno di tutte le altre ragioni che ci portano a parlare criticamente di qualcosa.
Quindi sì, di giudicare un po’ liberando la sregolatezza dei sensi.
Vuoi vedere che Rimbaud c’aveva ragione?
Hic et nunc, illico et immediate
Le promesse di Floating Points e Pharoah Sanders e del loro chiacchierato sodalizio sono una perfetta cartina da tornasole per capire se la domanda di Millard è valida ancora oggi, con qualche integrazione cucita sopra, per l’occasione.
I due si sono conosciuti ad un appuntamento al British Museum a Londra, dopo un primo approccio nel 2015, quando il leggendario sassofonista fu rapito da “Elaenia”, penultima acclamatissima fatica del produttore e neurobiologo di Manchester. Erano andati a vedere le sculture della dea della guerra Sekhmet, che secondo gli antichi Egizi generava il calore del deserto con il suo respiro, pur avendo poteri guaritivi e capacità di porre fine alle grandi epidemie. Sembra strano e un po’ cervellotico, sì, ma risulta un perfetto cavallo di Troia per parlare di come il linguaggio applicato al giudizio sull’arte, da cui avevamo iniziato, si è evoluto.
L’epopea del giudizio hic et nunc su un disco, come un’epidemia, è destinata ad essere ancora l’insidia maggiore quando costruiamo una vera e definitiva opinione?*
Partiamo da un presupposto: io credo che “Promises” legga la carta d’identità di Sam Shepherd ad alta voce, scandendo il suo CV fino al trafiletto “altri progetti”. È un bugiardino che recita le sue peculiarità, pregne di fattori che ti entrano nel cervello e ti fanno pensare di non aver mai sentito qualcosa di così potente. Altre volte, invece, ti restituiscono dei down cronici, che un po’ allontanano il concretizzarsi di quella stessa idea.
Parlando di Sanders, un protégé di John Coltrane e collaboratore di lungo tempo di un’altra Coltrane, Alice, c’è poco da aggiungere a quanto già noto: la sua leggenda si è mossa tra le deviazioni più spirituali e d’avanguardia del free-jazz, e per questo non risulta così strano che abbia proposto a Sheperd di scrivere un disco insieme, dopo essere stato per dieci anni in silenzio.
Ciò detto, e mi sembra risulti a qualche rompipalle come me, il suo contributo sembra parecchio mitigato dall’utilizzo, nell’arrangiamento, degli archi della London Symphony Orchestra, che per quanto centellinato ruba di parecchio la scena, quando esce fuori (ma questo non è per forza un bene o un male: forse rendono solo tutto più giusto). La loro operazione ricorda vagamente quanto avevano fatto Four Tet e Steve Reid, una decina d’anni fa, ma di cui è rimasta poca traccia rispetto al solco che “Promises” sembra profetizzare, a livello critico e dimensionale. E sì, si trattava anche di una collaborazione decisamente più elettronico–centrica.
La consacrazione di questo rinascimento cameristico (già spinta molto da realtà come Erased Tapes nell’ultimo decennio, ma raramente con risultati di tali portate) avviene sotto forma di un album che per un po’ è in cima alle classifiche di vendita UK, ma potrebbe benissimo essere un dig raro trovato su Discogs. E soprattutto, fa in modo che quella contaminazione tra un pubblico più teso al pop e un altro di adepti dell’elettronica, in un territorio in realtà sempre molto latente a certe latitudini europee, muovesse un discorso parecchio preso.
Citando le parole Federico Sardo su Esquire, «all’interno di Promises c’è evidentemente qualcosa che funziona e risuona con chi lo ascolta, tanto a livello superficiale quanto più profondo». E per me è un po’ l’effetto “Prati Bagnati del Monte Analogo”, che è stata ispirazione dichiarata di Shepherd, quando cominciò a scrivere il disco. La cima del monte immaginato da René Daumal e raccontato dalle note di Lovisoni e Messina, però, questo disco la vede solo in parte, e in pochi momenti: è difficile dire che stiamo realmente guardando nel passato di Sanders o nel futuro di Floating Points, quanto più in un “Elaenia” duepuntozero, senza equazioni elettroniche.
Tutto questo per dire che “Promises” è un disco che merita di essere discusso, a prescindere da ciò che si pensa, perché scatena riflessioni di diversissimo tipo. Ed è interessante che il dibattito si sia mosso come se in realtà le fazioni di pubblico fossero più generaliste, con tutti i pro e i contro del caso. Di questo strano cortocircuito ha parlato Giulio Pecci in un pezzo su Rolling Stone, sostenendo che «sia molto più interessante riflettere sull’immediato successo del disco e su cosa racconti del pubblico e della musica nel 2021, piuttosto che scannarsi per affibbiargli una definizione che solo lo scorrere del tempo può aiutare a chiarire»1.
L’incredibile impatto che ha avuto si è infatti mosso attraverso l’istinto cannibale dei tempi e dei suoi mezzi per comunicarlo, visto che il progetto è nel frattempo diventato anche un’installazione audiovisiva e si è aperto ad altre possibilità. Ma nel giro di qualche giorno, dopo essere stati la giuria demoscopica di noi stessi, non ne abbiamo più parlato.
Giustamente, il nostro senso critico non ha affatto sensi di colpa: ha fatto sua la veggenza del poeta, quella che sta in cima alla piramide del discorso.
Certo, ma in modo tutto suo.
Disco dell’anno
Il punto resta uno, cioè come dovrebbe o come potrebbe essere discussa musica come questa. Perché credo sia esattamente in questa deviazione che ci siamo persi dei pezzi importanti del discorso.
Nello spazio di quindici o forse vent’anni da quando il meta-linguaggio del web è un fattore, anziché rendere il dibattito sulla musica più articolato e stimolante, il tanto celebrato ignoto e il sincopato concetto di nuovo non sembrano mai stati meno interessanti. O meglio, lo sono per un periodo preoccupantemente breve, se relazionati alla materia di cui effettivamente spesso si discute.
Tra le definizioni che non potevamo prevedere diventasse vocabolario della critica c’è sicuramente “disco dell’anno”, la barra da social network per eccellenza, rarissimamente accostata ad un lavoro che rispecchia in fondo una nicchia, per quanto allargata questa possa essere. Ed è stata anche in questo caso pompata a dovere, ci mancherebbe.
Però, mi consenta, non sarà un tantino esagerato a volte farsi idea, dopo due-ascolti-due, che non uscirà più niente dal valore specifico di un disco (riuscito oggettivamente bene) per altri otto o nove mesi? Non sia mai che facciamo la fine di chi criticava Mozart. Quindi no, dai che non è esagerato.
Questa cosa qui è successa, anche se con una risonanza minore, per “Isles” del duo nordirlandese BICEP. Un altro disco che un po’ a sorpresa ha rubato le scene, trattandosi di materia più affine ai lettori di Resident Advisor. È un album che ha dentro le sfumature di quella club leggera (anzi leggerissima) che ogni tanto trova il momento giusto per uscire la testa fuori e triggerare la scena, ma che non è esattamente o sconvolgentemente materia così nuova, come si crede (ciao Kelly Lee Owens, se mi leggi, sono comunque tuo fan).
In una room su Clubhouse (oh vi ricordate Clubhouse?), pochi giorni dopo l’uscita del disco, qualcuno diceva in maniera convinta si trattasse già del disco dell’anno. “Isles” è uscito il 22 Gennaio. Quello di FP&PS, invece, è un disco nato nelle intenzioni quasi sei anni fa, iniziato realmente ad essere scritto nel 2019, uscito due anni dopo. Per qualche strano motivo, dopo una settimana per noi era superfluo parlarne più approfonditamente, ché un paio di ascolti per spararci la posa social bastano e avanzano.
(Non) c’è vita oltre la FOMO
Ok, insomma, ma allora cos’è che la critica si dovrebbe chiedere (o si sarebbe dovuta chiedere, a questo punto) per essere vero termometro della realtà e non una buccia di banana verso lo sconfinato regno delle opinioni da primo ascolto?
Per tornare a Rimbaud, lui nella ricerca di un linguaggio universale – nella poesia così come in realtà nella letteratura – ci vedeva il tentativo di far ritrovare l’arte in un territorio sconosciuto. Un’idea di linguaggio poetico, che appartiene un po’ al viaggio e un po’ alla magia, che parla del confine insieme vincolante e affascinante tra l’uomo e l’oltre.
È evidente che questa sia una pratica abbastanza facile da rendere epica e allo stesso tempo svilente, in modo intercambiabile, nella critica musicale odierna. Ma, sempre dal pezzo di Federico, «un disco, soprattutto in quest’epoca di mordi e fuggi, andrebbe valutato anche per il suo impatto, nel suo contesto, sulla sua durata nel tempo, su quello che saprà dire agli ascoltatori. E questo non possiamo farlo in un mese, figuriamoci in un giorno»2.
Volete uno spoiler? Una decina di giorni dopo le rispettive uscite, la vera FOMO apparteneva a chi “Promises” e “Isles” non li stava già mettendo nelle classifiche di fine anno. Suona la campanella del pub per l’ultimo giro, è già tardi.
Per chiudere, credo “Promises” sia un disco coraggioso, che apre quelle chiavi insolite di cui tutti stiamo parlando. Un po’ quello che cerchiamo di farci sbattere in faccia disperatamente, quando guardiamo una serie, leggiamo un libro, scrolliamo sul telefono, oggi. “Isles”, dal canto suo, suscita delle domande più classiche, ma che diventano occasione per capire quanti dischi di musica elettronica pura, con più serietà, si potrebbero ascoltare e consacrare con un giusto giudizio (e senza pregiudizio). Sì, insomma, per quanto i BICEP siano forti non credo siano esattamente «tra i pochi altri artisti in grado di evocare quei momenti di estasi da rave in modo così artistico»3. Su.
E se succede che un lavoro che non è jazz, non è elettronica, non è musica da camera (ma è tutti questi territori o nessuno, insieme) diventi la cosa più discussa in rete, credo la curiosità di capirci di più, con più pazienza, sia doverosa. In realtà, nel giro di poco, è una kryptonite per gli spiegoni astrali su quanto quanto è vero che doveva uscire trent’anni fa per essere apprezzato veramente, quanto doveva invece uscire fra altri trenta, per non sembrare un racconto sonoro della pandemia.
Il mio sospetto, ma credo si sia capito, è che anche in questo caso il tempo sia scaduto, e il piacere dell’ascolto sia stato sopraffatto ancora una volta dal guerilla marketing delle opinioni boostate come un annuncio su Instagram. Due ascolti alla volta, che vanno già benissimo per capire.
Peccato, perché del tempo per apprezzare meglio le cose andrebbe trovato. Peccato, perché sarebbe come riscoprire tutti un po’ di ecologia dell’ascolto.
Ma mi sa, caro Arthur, che non è questa l’epoca giusta.
*Sì.
G. Pecci, Amiamo Floating Points e Pharoah Sanders perché sono uno Xanax con una puntina di LSD, Rolling Stone Italia, 2021.
F. Sardo, Promises di Floating Points e Pharoah Sanders è davvero un capolavoro?, Esquire, 2021.
B. Jolley, Bicep – ‘Isles’ review: trippy electronic tales that transcend the club world, NME, 2021.